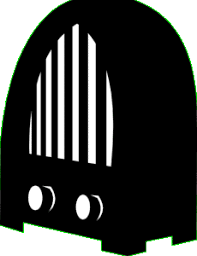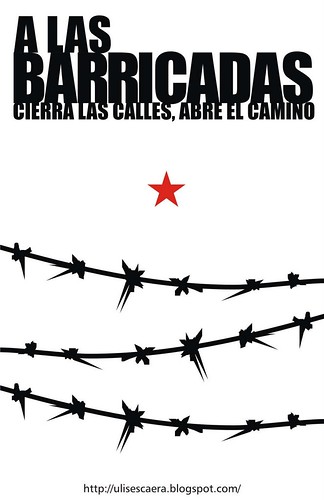Emilia Giorgetti
Sabino Gualinga è il leader spirituale del popolo Sarayaku – i discendenti del Giaguaro -, il cui territorio è incastonato in una zona remota dell’Amazzonia ecuadoriana. “Fin da bambino ho saputo tutto della foresta…conosco la sua vita, fino alla sua più piccola pietra” ha dichiarato nel suo idioma ancestrale di fronte alla Corte Interamericana dei Diritti Umani (CIDH) riunita a San José di Costa Rica nel dicembre del 2012, durante l’udienza che ha visto i Sarayaku vittoriosi contro l’Ecuador. Nessuno li avvisò quando, nel 2002, l’Ecuador concesse i diritti per la esplorazione petrolifera nel loro territorio. Per mesi gli uomini della compagnia, scaricati dagli elicotteri e protetti dall’esercito e dalla polizia, abbatterono alberi, trivellarono e minarono senza curarsi delle proteste pacifiche dei Sarayaku. Per anni i Sarayaku, decisi a far valere i propri diritti, lottarono e scalarono tutte le gerarchie fino ad arrivare alla CIDH e a vincere, ottenendo una sentenza storica: l’Ecuador è stato riconosciuto colpevole di violazione del diritto delle comunità indigene al consenso libero, previo e informato sull’utilizzo delle loro terre ancestrali – sancito dal trattato 169 dell’Organizzazione Mondiale del Lavoro e dalle Nazioni Unite -, è stato obbligato a risarcire i danni subiti dai Sarayaku e a bonificare il loro territorio dalle tonnellate di dinamite abbandonate dalla compagnia. “Chiediamo alla corte che ci protegga” queste le parole della portavoce dei Sarayaku a San José. “Chiediamo che ci lascino continuare in pace con la nostra vita. Sono ormai pochi i popoli indigeni. Anche l’Amazzonia sta scomparendo. Chiediamo di essere consultati quando si programmano attività dannose nei nostri territori. E, se diciamo ‘No’, chiediamo che si rispetti la nostra decisione.”
 Le sentenze della Corte, però, non fermano gli interessi economici che, poco a poco, consumano gli ultimi spazi di autonomia dei popoli nativi del continente americano. In Honduras, per esempio, il colpo di stato del 2009 e l’amministrazione che da questo è scaturita, hanno scatenato una vera e propria corsa all’accaparramento di terre ricche di risorse o che rivestono un interesse strategico per il controllo delle rotte del narcotraffico.
Le sentenze della Corte, però, non fermano gli interessi economici che, poco a poco, consumano gli ultimi spazi di autonomia dei popoli nativi del continente americano. In Honduras, per esempio, il colpo di stato del 2009 e l’amministrazione che da questo è scaturita, hanno scatenato una vera e propria corsa all’accaparramento di terre ricche di risorse o che rivestono un interesse strategico per il controllo delle rotte del narcotraffico.
La Mosquitia honduregna è una regione inaccessibile di foresta tropicale. Con il pretesto della lotta ai cartelli della droga, gli USA vi hanno già stabilito 3 basi militari dalle quali possono controllare un territorio che galleggia su un immenso lago di petrolio e i cui abitanti rappresentano solo un ostacolo ai progetti di sfruttamento o, nella migliore delle ipotesi, una fonte di mano d’opera docile e a buon mercato. Nelle prime ore del mattino dell’11 maggio del 2012, la popolazione di Ahuas udì gli elicotteri della DEA (agenzia statunitense per la lotta alla droga) volare basso sul fiume Patuca e poi gli spari. Secondo la versione ufficiale, due narcotrafficanti erano stati uccisi nel corso di una operazione antidroga. Ma non ci volle molto perché emergesse la realtà dei fatti: le vittime erano quattro indigeni misquitos – due donne incinta, un giovane e un ragazzo di 14 anni -, colpiti a morte mentre viaggiavano su una imbarcazione tradizionale lungo il fiume. Insieme a loro quattro feriti gravi, tra cui Wilmer, allora quattordicenne, dopo più di un anno ancora ricoverato in un ospedale di Tegucigalpa. E’ assistito dalla madre che, per stargli vicino, ha dovuto lasciare il lavoro e la famiglia e trasferirsi nella capitale. Per gli assassini, invece, nessuna conseguenza: il crimine è impunito come migliaia di altri nel paese.
 Le sentenze della Corte, però, non fermano gli interessi economici che, poco a poco, consumano gli ultimi spazi di autonomia dei popoli nativi del continente americano. In Honduras, per esempio, il colpo di stato del 2009 e l’amministrazione che da questo è scaturita, hanno scatenato una vera e propria corsa all’accaparramento di terre ricche di risorse o che rivestono un interesse strategico per il controllo delle rotte del narcotraffico.
Le sentenze della Corte, però, non fermano gli interessi economici che, poco a poco, consumano gli ultimi spazi di autonomia dei popoli nativi del continente americano. In Honduras, per esempio, il colpo di stato del 2009 e l’amministrazione che da questo è scaturita, hanno scatenato una vera e propria corsa all’accaparramento di terre ricche di risorse o che rivestono un interesse strategico per il controllo delle rotte del narcotraffico.La Mosquitia honduregna è una regione inaccessibile di foresta tropicale. Con il pretesto della lotta ai cartelli della droga, gli USA vi hanno già stabilito 3 basi militari dalle quali possono controllare un territorio che galleggia su un immenso lago di petrolio e i cui abitanti rappresentano solo un ostacolo ai progetti di sfruttamento o, nella migliore delle ipotesi, una fonte di mano d’opera docile e a buon mercato. Nelle prime ore del mattino dell’11 maggio del 2012, la popolazione di Ahuas udì gli elicotteri della DEA (agenzia statunitense per la lotta alla droga) volare basso sul fiume Patuca e poi gli spari. Secondo la versione ufficiale, due narcotrafficanti erano stati uccisi nel corso di una operazione antidroga. Ma non ci volle molto perché emergesse la realtà dei fatti: le vittime erano quattro indigeni misquitos – due donne incinta, un giovane e un ragazzo di 14 anni -, colpiti a morte mentre viaggiavano su una imbarcazione tradizionale lungo il fiume. Insieme a loro quattro feriti gravi, tra cui Wilmer, allora quattordicenne, dopo più di un anno ancora ricoverato in un ospedale di Tegucigalpa. E’ assistito dalla madre che, per stargli vicino, ha dovuto lasciare il lavoro e la famiglia e trasferirsi nella capitale. Per gli assassini, invece, nessuna conseguenza: il crimine è impunito come migliaia di altri nel paese.




















 Marcelino
Marcelino